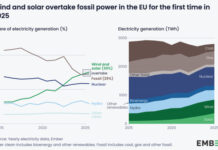La sostenibilità ha definitivamente oltrepassato il perimetro della retorica valoriale per entrare nel diritto positivo. Oggi si traduce in obblighi normativi, allocazione del rischio e, inevitabilmente, in nuove forme di conflittualità contrattuale. Nel punto di intersezione tra ESG e arbitrato internazionale si colloca oggi il Carbon Border Adjustment Mechanism, il CBAM: non un semplice strumento doganale, ma un dispositivo normativo capace di ridefinire le relazioni commerciali transfrontaliere e di generare nuove, sofisticate aree di conflitto giuridico.

Con l’entrata in vigore del regime definitivo nel gennaio 2026, il CBAM compie il suo salto di qualità. Da meccanismo di rendicontazione diventa un costo effettivo, indicizzato al prezzo dell’EU ETS, e dunque volatile, imprevedibile, strategicamente rilevante. Il carbonio incorporato nei beni importati non è più un dato tecnico: è una variabile economica che incide sulla marginalità, sulla competitività e, soprattutto, sulla tenuta dei rapporti contrattuali di lungo periodo. È qui che l’arbitrato entra in scena, non come strumento ancillare, ma come spazio naturale di governo delle frizioni generate da una regolazione climatica che travalica i confini statali.
L’obiettivo del CBAM
Il CBAM nasce con un obiettivo dichiarato: evitare il carbon leakage e garantire parità concorrenziale tra produttori europei e fornitori extra-UE. Ma il modo in cui questo obiettivo viene perseguito rivela una portata strategica ben più ampia. Il meccanismo non tassa il bene in quanto tale, bensì la sua intensità carbonica, obbligando l’importatore europeo a farsi carico, giuridicamente ed economicamente, delle emissioni generate a monte, spesso in giurisdizioni che non condividono né gli stessi standard ambientali né lo stesso impianto regolatorio.
Formalmente, il soggetto obbligato è l’importatore autorizzato. Sostanzialmente, l’intera catena del valore viene riscritta. I fornitori extra-UE, pur non essendo destinatari diretti del regolamento, sono chiamati a conformarsi a sistemi di monitoraggio, reporting e verifica modellati sul diritto europeo. In mancanza di dati sulle emissioni effettivamente incorporate nei beni importati, il regolamento impone il ricorso a valori predefiniti (defualt values) fissati dalla Commissione europea. Valori tutt’altro che neutri: sono costruiti sulle performance emissive dei produttori meno efficienti del settore e includono maggiorazioni progressive, pensate per rendere economicamente penalizzante qualsiasi opacità informativa.
Il messaggio è inequivoco: senza dati verificabili, il costo del carbonio aumenta artificiosamente. Si tratta di una sofisticata forma di pressione normativa indiretta, che non impone obblighi giuridici formali alle imprese extra-UE, ma ne condiziona in modo sostanziale l’accesso al mercato europeo. L’effetto è extraterritoriale nei risultati, pur restando formalmente interno nell’impostazione: chi
intende restare nella supply chain europea è spinto ad allinearsi agli standard di misurazione, monitoraggio e verifica dell’Unione.
Ciò disponendo, il CBAM non esporta il diritto europeo oltre confine; esporta i suoi incentivi economici, trasformando la trasparenza ambientale da virtù reputazionale a requisito competitivo.
Questo aspetto emerge con particolare forza nel rapporto transatlantico. Da un lato, l’Unione europea consolida un approccio regolatorio integrato, in cui CBAM, CSRD e obblighi di due diligence lungo la value chain compongono un mosaico coerente. Dall’altro, gli Stati Uniti presentano un quadro frammentato, segnato dall’assenza di una carbon tax federale, dal ridimensionamento delle climate disclosure rules e, in alcuni Stati, da una vera e propria reazione normativa anti-ESG. Il risultato è una discrasia profonda: imprese statunitensi chiamate, per via contrattuale, a rispettare standard europei che il loro ordinamento domestico non solo non impone, ma talvolta guarda con sospetto.
È in questo spazio di frizione che maturano le controversie. La ripartizione dei costi CBAM nei contratti di fornitura stipulati prima del 2026; l’accuratezza dei dati sulle emissioni e la responsabilità per sanzioni inflitte all’importatore; la qualificazione del CBAM come evento di hardship o come mutamento imprevedibile delle circostanze; la tenuta delle clausole ESG alla prova delle leggi locali.
Il ruolo dell’arbitrato
Proprio su queste nuove linee di conflitto si concentra oggi anche l’attività di studio e approfondimento di Camera Arbitrale di Milano, Società Benefit dal 2025, impegnata nell’analizzare l’impatto delle regolazioni climatiche emergenti sulla prassi arbitrale e sulla redazione dei contratti internazionali.
Tutte questioni che difficilmente trovano una risposta soddisfacente nei tribunali statali, incastrati tra norme di diritto pubblico, sovranità regolatoria e limiti di giurisdizione.
L’arbitrato internazionale si propone allora come una forma di “private governance” del rischio climatico. Non perché sostituisca il diritto pubblico, ma perché lo traduce in allocazioni contrattuali di rischio, verificabili ed eseguibili. La sua forza risiede nella neutralità, nella flessibilità procedurale e nella possibilità di affidare la decisione a tribunali competenti non solo giuridicamente, ma anche tecnicamente. Carbon accounting, modelli di calcolo delle emissioni, verifiche scientifiche: l’arbitrato è in grado di maneggiare questa complessità senza semplificarla.
Non mancano, tuttavia, le zone d’ombra. La tradizionale riservatezza dell’arbitrato entra in tensione con l’interesse pubblico che permea le controversie ESG. Senza un minimo di trasparenza, il rischio è la frammentazione delle decisioni e l’assenza di una prevedibilità sistemica. Allo stesso tempo, la quantificazione del danno in contesti legati al CBAM resta una sfida aperta: dimostrare il nesso causale tra dati inesatti, danno economico e impatto ambientale non è operazione lineare, né dal punto di vista giuridico né da quello probatorio.
Eppure, nonostante questi limiti, la traiettoria è tracciata. Il CBAM segna il passaggio definitivo dalla sostenibilità volontaria alla sostenibilità coercitiva. Le imprese non sono più chiamate a dichiarare buone intenzioni, ma a gestire rischi concreti, misurabili, sanzionabili. In questo scenario, l’arbitrato non è un ripiego, ma uno snodo strategico: il luogo in cui il diritto del commercio internazionale incontra la regolazione climatica e tenta di ricomporne le fratture. Il carbonio è entrato nei contratti. E, inevitabilmente, anche nei tribunali arbitrali. Chi saprà leggere per tempo questa evoluzione non si limiterà a difendersi dal contenzioso: userà l’arbitrato come strumento di governo del cambiamento, trasformando un obbligo regolatorio in una leva di stabilità e di vantaggio competitivo. Perché, nel nuovo ordine economico che si va delineando, il valore di un bene non si misura più solo in termini di prezzo, ma anche, e sempre più, in termini di integrità ambientale.
Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.